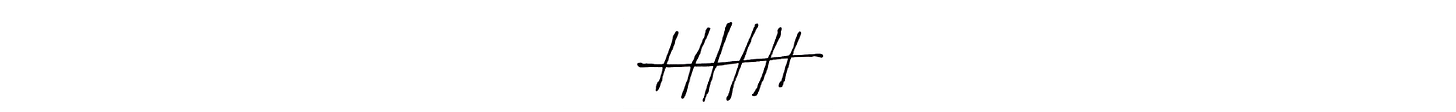due: spade
dove leggerete di armi incantate medievali, di come abbiamo smesso di usare quelle non magiche per dirimere le liti e di che cosa c’entrino i droni omicidi con le lame di Tolkien
Spada son contro ogni arma mortale, né lanza né azza né daga contra mi vale. [...] Chi contra me farà ben lo farò languire. E son Reale e mantengo la justicia, la bontà acresco e destruzo la malizia.
– Fiore de' Liberi da Primeriacco, Flos duellatorum in armis, sine armis, equester et pedester (1404)1
Fare la Storia a fil di spada: miti norreni, fanfiction cristiane, sbudellamenti aristocratici
Dopo i dinosauri, le spade sono con ogni probabilità la cosa preferita di qualsiasi bambino maschio, prima che gli ormoni dell’età puberale lo devastino.
È probabile che sia a causa di una incrollabile eredità infantile se la mia memoria funziona così: sono in grado di recitare come il padre nostro i nomi di almeno duecento Pokémon, le sole creature che abbiano rivaleggiato con i sopracitati lucertoloni per il mio amore di bambino.
Alla bisogna, con un certo imbarazzo, scovo nel mio palazzo mentale anche un lungo catalogo di spade - sacre, profane, maledette, parlanti, di stazza variabile - presenti nei romanzi fantasy e nei manuali di Dungeons & Dragons che hanno accompagnato la fase di più abissale sfiga della mia vita. Se invece devo richiamare a coscienza le date dei compleanni dei miei affetti più cari ho bisogno dell’aiuto da casa.
La spada più nota al mondo - e per questo metafora prediletta di innumerevoli battute a sfondo fallico - è forse Excalibur, l’arma prediletta di Re Artù. Come spiega lo storico Robert W. Jones - che nel tempo libero ama brandire mostruose Zweihander, quindi c’è da fidarsi - si tratta della lama che insieme alla Durlindana di Orlando e alla Gramr di Sigfrido ha fissato l’immagine canonica delle spade incantate, già presenti nella tradizione pagana scandinava come oggetti-persona, a volte dotati di volontà propria.2

Il fatto imbarazzante è che Excalibur, a parte scintillare parecchio, non ha dei gran poteri: in effetti non le occorrono, perché rappresenta il potere. Le origini mistico-bellico-politiche delle spade in Europa si perdono nelle brume dell’Età del Bronzo (2300-800 a.C.), ma è nell’XI secolo, l’inizio dell’età della cavalleria, che la loro potenza simbolica raggiunge la massima fioritura. Quell’età d’oro sarebbe stata impossibile senza un aiutino del cristianesimo: non è un caso che, nel ciclo arturiano, il giovane re riesca a estrarre la spada dalla proverbiale roccia sempre in momenti cruciali per la liturgia cattolica. Lo storico Francesco Marzella è poi risalito a un curioso episodio agiografico molto simile a quello di Excalibur, riferito dal monaco Aelredo di Rievaulx.3
Wulfstan, arcivescovo di Worchester, era stato costretto a dimettersi dal sacerdozio a causa della propria simplicitas. Per dimostrare di essere ancora degno del proprio titolo, conficcò il proprio bastone pastorale nella tomba di re Edoardo il Confessore, e sfidò gli altri uomini di chiesa a estrarlo. Nessuno ce la farà: è una chiara cristianizzazione della leggenda, pagana, della spada nella roccia.
Nel Medioevo, potere temporale e potere spirituale si cambiano d’abito mitologico mentre definiscono i rispettivi domini. Papa noto per essere il preferito di Dante, Bonifacio VIII descrisse questa diarchia con la metafora delle due spade nella bolla Unam sanctam, promulgata il 18 novembre 1302.4

Le spade però non furono solo un orpello metaforico. Nell’Alto Medioevo, stringendole in pugno, si formò l’aristocrazia, ossia la classe sociale che dominerà l’Europa sino alla Rivoluzione Francese: una banda di professionisti della violenza, che proteggono e minacciano con la spada, esercitano la forza di legge con la spada, vengono investiti del proprio potere con la spada, combattono guerre di religione e consolidamento territoriale a colpi di spada, costruttori di stati che roteano e abbattono spade sulle capocce altrui.
Nei secoli a venire, lo sbudellamento come professione diventerà una carriera sempre meno attraente. All’altezza del Seicento, mentre la corte di Francia si riempie di funzionari protoborghesi incaricati dal re, soprannominati “nobiltà di toga”, i discendenti delle bande armate di cui sopra saranno chiamati, per distinguerli, “nobiltà di spada”.
Stacca, capo: l’età moderna, ovvero come abbiamo disimparato a fare i duelli
La nascita stessa di una nuova categoria aristocratica era il segno di un declino. I padroni d’Europa detenevano il monopolio legittimo della violenza in un dato territorio perché quella violenza sapevano esercitarla direttamente: ora erano in via d’estinzione, diluiti dentro le mollezze della vita cortigiana. È la tesi del sociologo Norbert Elias sulla nascita del concetto di “civiltà”:
Mentre la nobiltà guerriera cavalleresco-feudale andava lentamente scomparendo per lasciare il posto alla nuova aristocrazia di corte di tendenza assolutistica, contemporaneamente nel corso del XVI e del XVII secolo il concetto di «civilité» prese lentamente il sopravvento come espressione di un comportamento adeguato alla società5.
È una trasformazione che si espresse anche nei codici del buon comportamento a tavola. Vediamo un passo di un famosissimo manuale di galateo citato da Elias: «non servitevi del coltello puntandolo contro il viso, perché questo è pericoloso e suscita spavento6». In un altro trattato di buone maniere, The Habits of Good Society, del 1859, sta scritto: «tutto ciò che può essere tagliato senza ricorrere al coltello sia tagliato con la sola forchetta».
Non è un caso, prosegue Elias, che in Cina, paese per tradizione retto da una burocrazia celeste di funzionari colti, a volte si dica che gli europei sono barbari perché mangiano servendosi delle spade.
L’età moderna nasce e cresce segnata dalla lenta ma inesorabile sparizione del desiderio di andare a crepare di morte violenta in nome di un fine superiore: la maggior gloria di Dio, la potenza di uno Stato, l’Onore. Tutte questi sostantivi maiuscoli vengono polverizzati dalla minuscola vita individuale, oltre la quale non c’è nulla per cui valga la pena di rischiare la pelle. In altre parole, l’età moderna coincide con la vittoria dell’idea che conti solo la propria vita biologica, e null’altro.
Lo sviluppo del romanzo occidentale è forse la vicenda che più di tutte racconta il trionfo di questa visione del mondo.7 C’è una scena che mi sembra dimostrarlo alla perfezione in un libro che avevo cominciato nei primi anni dell’università e che ho finito solo l’anno scorso: L’educazione sentimentale di Gustave Flaubert.
Per una sequela di scemenze che non ho voglia di ricostruire qui, il protagonista, Frédéric Moreau, giovane cinico, disilluso, innamorato, sfida a duello il visconte di Cisy. Scopriamo dal narratore onnisciente che nessuno dei due ha un gran desiderio di combattere. Gli amici dei due cercano di far desistere i litiganti, ma senza riuscirci: bisogna salvare la faccia.
Arrivato il giorno del duello, i due impugnano le spade. Il visconte è pallidissimo, la punta della lama trema «come un frustino». Non ha l’aria da guerriero, e infatti sviene ancor prima che Frédéric sferri un colpo. Rianimato, il duello è interrotto: il primo sangue è stato già versato, perché nella caduta il nobile s’è scorticato il pollice della mano sinistra.
Nel romanzo la violenza assumerà caratteri più cupi, ma sarà sempre un’immagine lontana, anche nel momento di maggiore vicinanza. Quando la vita di Frédéric incrocia i moti del 1848 e la loro atroce repressione, il protagonista, come osserva il critico letterario Guido Mazzoni, «passa attraverso gli scontri come se la sua vita fosse separata dagli eventi collettivi». Scrive Flaubert:
I feriti che cadevano, i morti distesi non avevano l'aria di feriti veri, di morti veri. Gli sembrava di assistere a uno spettacolo.8
L’educazione sentimentale viene pubblicato in Francia nel 1869. Nello spazio di cinquant’anni, l’Europa e il mondo saranno sconvolti dalla guerra che non fece finire tutte le guerre, ma a partire dalla quale, in un certo senso, le spade incantate ripresero un posto d’onore nella narrativa occidentale.
Il professor Tolkien in trincea, oppure: come ho smesso di preoccuparmi dell’Unico Anello e ho iniziato ad amare la Contea
Esser colti di sorpresa in gioventù dal 1914 non fu un’esperienza meno orribile che farsi coinvolgere nel 1939 e negli anni seguenti. Nel 1918 tutti i miei migliori amici tranne uno erano morti.9
Prima ho parlato di sfiga abissale, ma la verità è che alcuni dei momenti più felici della mia adolescenza li ho trascorsi giocando a una campagna di Dungeons & Dragons sul forum di Nonciclopedia, la versione demenziale di Wikipedia. A ripensarci, è piuttosto paradossale che quelle centinaia di ore di allucinazione ludica avessero come matrice la tragedia di un ragazzo mandato a morire in trincea, che si chiamava John Ronald Reuel Tolkien. Lo dice meglio il giornalista John Garth:
How strange it is that J. R. R. Tolkien should have embarked upon his monumental mythology in the midst of the First World War, the crisis of disenchantment that shaped the modern era.10
Un anno prima di entrare nei ranghi dell’esercito inglese, Tolkien era uno studente di Oxford a cui il latino e il greco non piacevano granché. Preferiva il Beowulf all’Iliade. È dallo studio della lingua inglese antica che inizia a germogliare l’elfico o Quenya, la prima lingua della Terra di Mezzo a essere inventata. Non studiava soltanto, però. I suoi migliori amici all’università provenivano come lui dall’alta borghesia inglese. Insieme a loro giocava a rugby, leggeva, beveva il te, cazzeggiava.
Tolkien era un ufficiale delle comunicazioni nell’undicesimo battaglione dei Fucilieri del Lancashire quando, nel luglio del 1916, si trovò in Francia, dentro a uno degli scontri più terribili di tutta la prima guerra mondiale. Un aviatore dei Royal Flying Corps che sorvolava l’area descrisse la prima battaglia della Somme «as if Wotan, in some paroxysm of rage, were using the hollow world as a drum». I morti e i dispersi su entrambi i fronti furono centinaia di migliaia. Tra questi, due erano gli amici più cari di Tolkien.
A salvarlo dalla morte sul campo forse furono i pidocchi. Tolkien si beccò, come la descrisse, «a pyrexia of unknown origin»: era la febbre delle trincee, una malattia infettiva trasmessa dal morso degli insetti che furono suoi coinquilini sulla linea del fronte. Sviluppò sintomi tanto gravi che dovettero trasferirlo in un ospedale di campo tra il 28 e il 30 ottobre 1916. In quei due giorni, i mortai tedeschi bombardarono a volontà il suo battaglione. Fu durante la convalescenza che continuò a fare quello che faceva quando era uno studente: inventare lingue, scrivere storie. Una parte rilevante della grammatica dell’elfico fu sviluppata da un ventiquattrenne che sfebbrava su un letto d’ospedale a Birmingham, mentre metà di una generazione moriva per l’eccellente funzionamento dei più recenti progressi della tecnica militare.
Il Signore degli Anelli non è una metafora, e neppure un’allegoria: la storia che racconta basta a sé stessa, e non ha bisogno di riferirsi a eventi reali per acquistare maggior senso. Tolkien non era d’accordo con chi paragonava l’anello alla bomba atomica, e rifiutava gli accostamenti dei suoi libri ai conflitti mondiali. Quel che è certo, però, è che il mondo fantastico di Tolkien non sarebbe stato lo stesso senza le guerre del Novecento.
Come ricorda Wu Ming 4, non solo la prima, ma anche la seconda guerra mondiale riguardò da vicino Tolkien. Il suo paese rischiava di essere invaso e sottomesso, e suo figlio Christopher era arruolato nell’aviazione britannica contro un nemico verso il quale il padre, non proprio un bolscevico, scrisse parole durissime:
Comunque in questa guerra io ho un bruciante risentimento privato, che mi renderebbe a quarantanove anni un soldato migliore di quanto non fossi a ventidue, contro quel dannato piccolo ignorante di Adolf Hitler [...]. Sta rovinando, pervertendo, distruggendo, e rendendo per sempre maledetto quel nobile spirito nordico, supremo contributo all’Europa, che io ho sempre amato, e cercato di presentare in una giusta luce.11
Tolkien vide i codici della guerra cambiare sotto ai propri occhi: l’onore cavalleresco, se mai era stato valido fuori dai poemi, ora era cancellato. Il filosofo Peter Sloterdijk sostiene che, dall’Alto Medioevo fino all’inizio della prima guerra mondiale, ogni conflitto umano si basava su una certezza: un soldato doveva avere la ferma intenzione di uccidere un bersaglio, perché prendere di mira un avversario significava perseguire con altri mezzi balistici la logica del duello. Due persone si affrontavano, e ognuna poteva dare la morte all’altra.

Con la prima guerra mondiale, invece, non si presero più di mira i corpi dei singoli combattenti, ma lo spazio che occupavano, l’ambiente in cui vivevano.12 I cannoneggiamenti diretti sulla base delle mappe, i bombardamenti aerei, le nubi di gas tossico stabilirono un nuovo ordine bellico, al quale è difficile non pensare quando leggiamo di draghi sputafuoco che radono al suolo intere città o di enormi occhi fiammeggianti che ci scrutano dall’alto di una torre. È come se Tolkien si fosse rivolto a un Medioevo fantastico per sognare un’altra etica della guerra, sopra la quale la realtà storica allungava la sua ombra.
Sin dalle prime pagine, non sembra ci sia una gran voglia di combattere nel Signore degli Anelli. Quella degli hobbit è una deliziosa società cottagecore, borghese e discreta, nella quale le strepitose ricchezze portate a casa dalle avventure di Bilbo Baggins rappresentano una chiacchieratissima stravaganza. Figuriamoci la guerra: quando Bilbo lascia l’anello a Frodo, gli sconfinamenti di orchi e lupi nella Contea vivono soltanto nei ricordi dei vecchi.
La Contea ha ancora una scorta d’armi, ma sono ormai trofei, raccolti in un museo chiamato Casa Mathom. È un nome che la dice lunga sullo spirito guerriero dei protagonisti dell’epica di Tolkien: «tutto ciò che non era d’uso immediato ma che erano restii a buttare, gli Hobbit lo chiamavano mathom. Le abitazioni tendevano a riempirsi oltremisura di mathom e nel novero rientravano molti dei regali che si scambiavano».13 Somigliano ai cesti aziendali ricevuti a Natale.
Nonostante le armi all’inizio siano riposte nello sgabuzzino, il mondo di Tolkien pullula di spade incantate e potenti, con un ruolo fondamentale nella storia. Una di loro è anche il motivo per cui, quando avevo sei anni, mi sono rifiutato di andare al cinema a vedere il Signore degli Anelli. Alla mia domanda “ma fa paura?”, mio padre - che credo avesse una gran voglia di vederlo - aveva vagheggiato un “ma nooooo”, per poi pensarci su e aggiungere titubante che una delle prime scene, dove un buono mozza due dita a un cattivone con una spadata, poteva forse risultare inadatta a un bambino fifone come me.
Quel tizio si chiamava Isildur. Raccolta Narsil, la spada spezzata del padre morto, re Elendil, con una favolosa botta di culo riesce a togliere anello e anulare al malvagio Sauron. Di lì a poco, Isildur passerà da giovane promessa a solito stronzo: sarà lui a rifiutare di distruggere l’anello, gesto dal quale eccetera eccetera. Ma è di un altro personaggio che mi preme parlarvi: uno che produce notevoli quantità di sofferenza e terrore nel mondo vero, per mezzo di una versione aggiornata al XXI secolo della lama che mi faceva tanta paura.
Le due Anduril: affinità-divergenze tra la ricezione di Tolkien a Colle Oppio e nella Silicon Valley
Anduril è il nuovo nome che la spada spezzata di cui sopra assume una volta riforgiata dagli elfi. Sarà poi consegnata ad Aragorn, che al termine della trilogia diventerà il nuovo re buono e pacifico della Terra di Mezzo. Nel film di Peter Jackson è interpretato da Viggo Mortensen, che nella versione italiana è doppiato da Pino Insegno: un uomo relegato negli anfratti più reconditi della mia memoria fino a quando, due anni fa, ha chiuso la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per presentare il futuro presidente del consiglio Giorgia Meloni recitando un riadattamento del discorso di Aragorn agli eserciti uniti.

Non mi dilungo sugli usi e gli abusi di Tolkien fatti dalla destra postfascista in Italia perché Wu Ming 4 ha scritto e detto sul tema quasi tutto ciò che occorre sapere.14 Ricordo una presentazione del libro Difendere la Terra di Mezzo a Torino in cui proprio Wu Ming 4 ironizzava sul fatto che, mentre in Italia le giovani crape pelate del Movimento Sociale Italiano s’inventavano i Campi Hobbit, negli Stati Uniti Tolkien era un riferimento per il movimento psichedelico e gli hippie: una discreta differenza nella quota di divertimento potenziale.
Ciò che manca a questa giustamente sghignazzante ricostruzione è che però, una volta passata la sbornia di droghe ed escapismo, oggi in California il mondo di Tolkien è associato a ben altre attività. Almeno due importantissime aziende tecnologiche nate nella Silicon Valley hanno un nome in Quenya. La prima è stata fondata dall’imprenditore Peter Thiel, padre spirituale di Elon Musk e della cosiddetta Paypal mafia. Si chiama Palantir come le pietre veggenti di Tolkien e si occupa di sviluppare software per difesa e sicurezza. La seconda invece è Anduril, che non è più solo il nome di una spada, ma la cui traduzione è sempre Fiamma dell’Occidente.
Anduril è stata fondata da Palmer Luckey, il figuro di cui vi accennavo alla fine del precedente paragrafo. Credo che la cover che ha scelto per il proprio profilo X possa fornirvi un quadro piuttosto eloquente del soggetto:

Come ha scritto Alessandro Aresu, Palmer Luckey è un cosplayer, ma è anche un costruttore: è anche uno dei principali esponenti della Paypal Mafia a essere entrato nel nuovo Deep State di Donald Trump. Prima di diventare un weaboo che sviluppa sistemi d’arma autonomi, Luckey è stato un weaboo che, dopo aver abbandonato il college, s’è inventato Oculus, un’azienda di visori per la realtà virtuale che è stata finanziata da Thiel per poi essere venduta a Facebook nel 2014.
Oggi questi due aspetti del lavoro di Luckey convergono: l’11 febbraio 2025, Luckey ha annunciato che Anduril assumerà la supervisione dell’Integrated Visual Augmentation System dell’esercito statunitense, prima in mano a Microsoft: l’hardware e il software dei visori di realtà aumentata usati dai soldati americani passeranno per le mani di un tizio che indossa solo braghe corte, infradito e camicie hawaiane, che ha chiamato la propria azienda come la spada di un mondo fantastico, che possiede un’azienda di retrogaming, che parla delle tecnologie che sviluppa come gadget essenziali per dei supereroi e che si autodefinisce un “sionista radicale”.

Quando parliamo di sistemi d’arma autonomi parliamo, nel caso di Anduril, soprattutto di aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero di droni. Il 6 marzo 2025, il ministero della difesa del Regno Unito ha annunciato di aver concluso un accordo da 30 milioni di sterline con Anduril. Quei soldi saranno spesi per rifornire l’esercito ucraino di velivoli della linea Altius.
Secondo il filosofo Grégoire Chamayou, i droni realizzano «un antico desiderio che anima tutta la storia delle armi balistiche: accrescere la propria lontananza in modo da poter colpire il nemico a distanza, prima che questo sia in grado di farlo a sua volta15». La guerra passa da asimmetrica a unilaterale. Si fonda sulla possibilità di somministrare morte per via videoludica: spada e feritoia dell’elmo diventano controller e visore. La lingua che sorregge la Terra di Mezzo, il mondo nel quale Tolkien cercava una via di fuga dall’incubo della guerra moderna, oggi alimenta una tecnica orchesca.
Come si sa, gli Orchi sono creature malvagie e crudeli. Non fanno cose belle, però ne fanno molte di ingegnose. [...] Non è improbabile che abbiano inventato alcune delle macchine destinate ad affliggere il mondo, specialmente gli ingegnosi congegni per uccidere un gran numero di persone tutte insieme.16
Non sono solo il Quenya e le spade magiche a essere tracimati dalla Terra di Mezzo al pianeta Terra: sono arrivati anche gli Orchi.
Residuati
Amado Crowley, figlioccio (a suo dire) di Aleister Crowley, scrisse un manuale di magia sessuale chiamato Excalibur
Tolkien era un discreto burlone: si travestiva da guerriero anglosassone e inseguiva i propri vicini di casa brandendo un ascia per divertirsi
Tolkien spiega alla BBC la spinta originaria a scrivere il Signore degli anelli - e il tema universale di tutte le storie - citando Simone De Beauvoir (spoiler: è l’inevitabilità della morte)
Excalibur era il nome di un periodico di giochi di ruolo italiano fondato da Giovanni Ingellis, primo traduttore di Dungeons & Dragons in Italia ed editore della prima edizione di Magic: l’adunanza
MMA medievale dentro a un ottagono? MMA medievale dentro a un ottagono
Anche noto come Fior di battaglia, è il più antico trattato di scherma arrivato a noi, ed è scritto in versi: un motivo in più per esser favorevoli all’introduzione delle armi bianche nelle serate di slam poetry.
Robert W. Jones, A Cultural History of the Medieval Sword: Power, Piety and Play, Boydell Press 2023
Francesco Marzella, Wulfstan, Artù e la prova della spada, «Studi Medivali» Bd. 54 2013. Marzella ha anche pubblicato un libro su Excalibur per Solferino e uno su Re Artù per Laterza
«In hac ejusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur»
Norbert Elias, La civiltà delle buone maniere (1939), il Mulino 1982
William Caxton, Book of Curtesye (1477)
Guido Mazzoni, Teoria del romanzo, il Mulino 2011
Gustave Flaubert, L’educazione sentimentale (1869), Garzanti 1966, traduzione di Giovanni Raboni
J.R.R. Tolkien, Prefazione alla seconda edizione inglese del Signore degli Anelli (1966), Bompiani 2019, traduzione di Ottavio Fatica
John Garth, Tolkien and the Great War. The threshold of Middle-Earth, Houghton Mifflin Company 2003
J.R.R. Tolkien, La realtà in trasparenza: lettere 1914-1973, Bompiani 2001, lettera n. 45
Peter Sloterdijk, Terrore nell’aria (2001), Meltemi 2006
J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli (1966), Bompiani 2019, traduzione di Ottavio Fatica
Qua trovate una bella intervista del 2023 sugli ultimi sviluppi del rapporto tra destra italiana e Tolkien fatta a Wu Ming 4 da Valerio Renzi, nella sua newsletter S’è destra, che vi consiglio di seguire
Grégoire Chamayou, Teoria del drone (2013), DeriveApprodi 2014
J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit (1937), Bompiani 2012, traduzione di Caterina Ciuferri